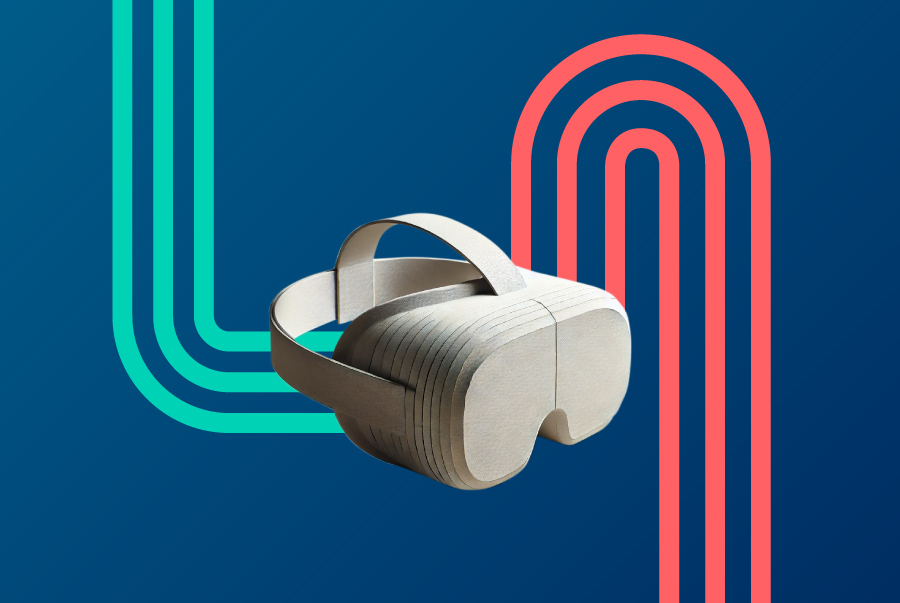Grazie a una preziosa segnalazione di Giorgio Rutelli ho letto Ipnocrazia di Jianwei Xun (ma esisterà davvero?) . Volume illuminante. Non sto qui a sintetizzare il testo, si trovano già molte recensioni puntuali in rete. Vorrei però condividere l’utilità di leggere un libro che offre un salto di qualità nella lettura dei fenomeni di cui stiamo discutendo un po’ tutti in questi giorni, per ragioni politiche o professionali.
Ipnocrazia suggerisce – tra l’altro – che viviamo in un mondo nel quale la distinzione tra realtà e finzione non è più rilevante, perché semplicemente impraticabile: con l’IA non posso più “credere ai miei occhi”. Tutto può essere simulato, manipolato e modificato per produrre artefatti che sembrano reali e soprattutto sono verosimili.
Non c’è più vero o falso ma solo l’infinita proliferazione di possibilità. Il reale non può essere posseduto, verificato o conquistato. Lo si può soltanto guardare svanire.
Ma anche questo non è più importante, perché alcuni leader politici e di opinione su scala globale immettono nei circuiti dell’informazione una mole di affermazioni tale da contribuire a quell’overload informativo che rende impossibile provare a rispondere alle domande “è vero?” o “è reale?” (c’è una distinzione che proverò a spiegare più avanti). Bannon ha teorizzato questa pratica come uno dei modi per sopraffare gli avversari (lo spiegava bene Luca De Biase sul Sole 24 Ore giovedì scorso).
L’overload informativo serve a esaurire le risorse cognitive fino al punto in cui la suggestione può penetrare più facilmente.
Per Xun il flusso continuo di informazioni in cui siamo immersi dà vita a realtà distinte, abitate da persone che vi trovano ragioni d’essere, fonti autorevoli ed esperti credibili. Ovviamente noi contribuiamo a questo processo attivamente (e lo sappiamo dal secolo scorso: “La costruzione sociale della realtà” dei sociologi Berger e Luckmann è del 1966, “La realtà inventata” dello psicologo Watzlawick è del 1981) ma la novità è che adesso questa partecipazione è continua, permanente e pervasiva grazie alla presenza nelle reti sociali cui prendiamo parte attraverso le piattaforme digitali e alle quali aggiungiamo contenuti straordinariamente personali come quelle esperienze che ambirebbero a divenire semplicemente ricordi.
Non sono meramente sistemi tecnologici in competizione; sono quadri ontologici concorrenti, modi diversi di strutturare l’esperienza e la coscienza umane.
Come dicevo in apertura, a mio avviso la lettura di Xun aiuta a fare un salto di qualità nell’interpretazione dei fenomeni che stiamo vivendo. Al tempo stesso presenta un limite cruciale: l’autore di Ipnocrazia attribuisce la definizione di deliberata, consapevole e intenzionale “alterazione di stati di coscienza” a quello che probabilmente e semplicemente è lo sviluppo cognitivo dei Sapiens, determinato dalla straordinaria plasticità del nostro cervello e dall’interazione tra il mondo fisico che ci è stato dato e l’ambiente artificiale che abbiamo creato. Oppure a quello che i sociologi chiamano “effetto emergente” dell’interazione spontanea di più persone (migliaia, milioni), che compiono scelte non concordate né coordinate eppure capaci di sortire effetti strutturali. Il soggetto di questa supposta intenzionalità è “il sistema” (ahi): quanti errori sono stati compiuti in nome della lotta al “sistema”, un simulacro che solleva dalla responsabilità di definire la causa dei fenomeni che gli si attribuisce. L’autore cita Trump e Musk e questo aiuta a capire qualcosa degli “agenti” di questo sistema, e tuttavia le relazioni tra questi ed altri protagonisti della vita economica e politica del nostro tempo sono meritevoli di esplorazioni più approfondite, perché senza un’analisi specifica non avremo strumenti di difesa personale e collettiva.
Trump e Musk sono i profeti di questo regime. Non sono semplicemente figure di potere: sono dispositivi narrativi. Le loro narrazioni non cercano la verità, ma lo stupore. […] non mirano a convincere ma a incantare. […] La loro irrazionalità funzionale non è un difetto ma una feature […]
Una piccola postilla, come avevo anticipato. Ritengo che la “verità” sia un attributo dell’informazione: il fact-checking valuta la corrispondenza tra il contenuto di un’informazione e la realtà cui fa riferimento. La realtà in quanto tale è più sfuggente, ha a che fare con la nostra (dei Sapiens intendo) capacità di conoscere. L’indagine sul rapporto tra realtà e apparenza, tra realtà e percezione comincia con Democrito e Platone, continua con Locke e Kant, inquieta i neuroscienziati contemporanei (fatevi due risate su quello che avete sempre creduto vero, leggendo “L’illusione della realtà” di Donald Hoffman). Se il mondo in cui agiamo presenta realtà alternative (ben oltre fatti e verità alternative), il rischio di incomunicabilità tra persone che abitano due realtà diverse è altissimo. E le conseguenze non possono che essere nefaste.
Non si tratta semplicemente di forme di disaccordo sui fatti, ma di manifestazioni di sistemi di realtà separati, ciascuno completo di proprie prove, esperti e quadri epistemologici.